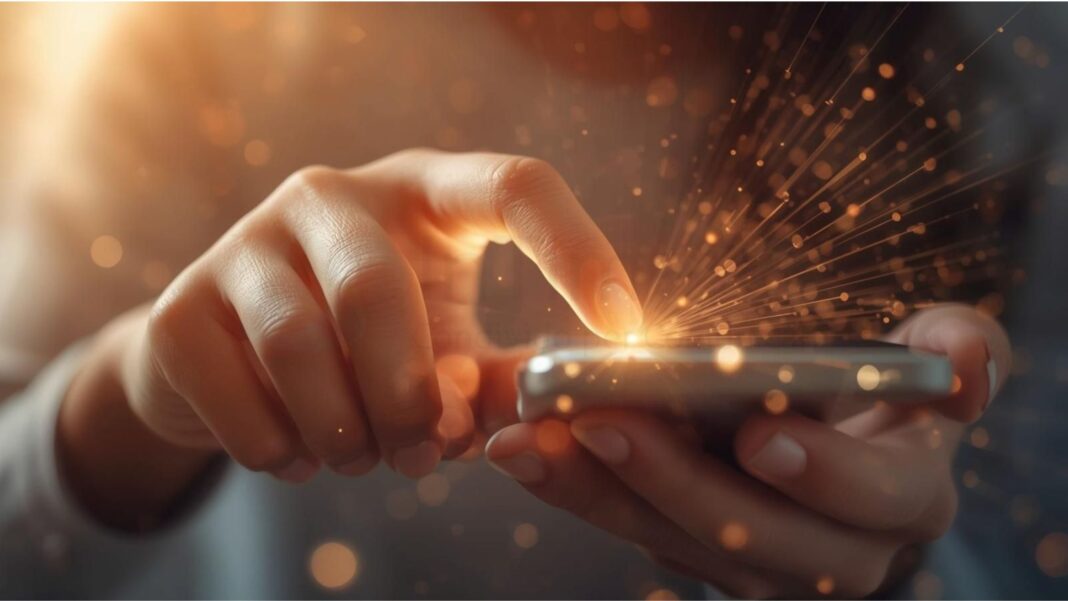Il debutto di “Info sul tuo account” su X, pensato per rendere più trasparenti i profili, ha prodotto confusione, errori, localizzazioni imprecise. Si è quindi riacceso il dibattito sul ruolo della piattaforma nella lotta alla disinformazione. Ecco tutto quello che è successo.
Quello che doveva essere un passo avanti verso la trasparenza e verso la lotta alla disinformazione, si è rivelato un mezzo pasticcio.
Annunciata da settimane, alla fine X ha lanciato il fine settimana appena trascorso la funzione “Info sul tuo account”. Immediatamente dopo si è innescata una serie di situazione che dimostrano quanto sia complesso portare trasparenza in un ambiente dove l’autenticità è merce sempre più rara.
Nel giro di 48 ore dalla sua attivazione, la funzione è stata temporaneamente disattivata, poi riattivata con modifiche sostanziali, mentre migliaia di utenti si sono ritrovati a scoprire che account con centinaia di migliaia di follower, che si presentavano come “patrioti americani”, erano in realtà gestiti da Paesi lontani migliaia di chilometri dagli Stati Uniti.
Il caso più eclatante ha coinvolto addirittura l’account del Dipartimento di Sicurezza Nazionale statunitense, con screenshot diventati virali che lo mostravano come “basato in Israele” prima che la funzione sparisse improvvisamente nella notte di venerdì scorso, 22 novembre 2025.
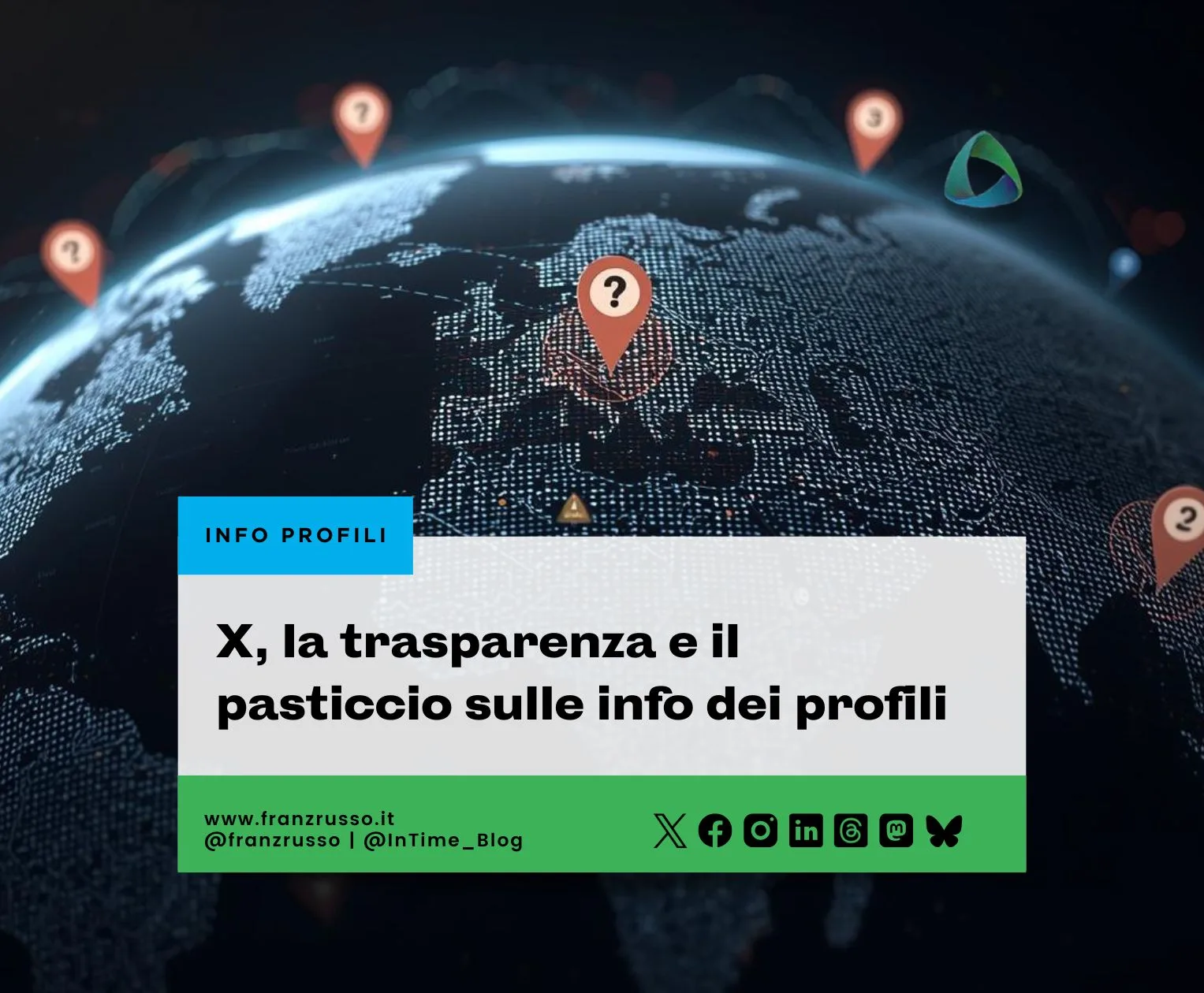
Come si è arrivati a Info sul tuo account
Come dicevo all’inizio, la funzionalità era arrivata già il 14 ottobre 2025, quando Nikita Bier, responsabile prodotto di X dal luglio di quell’anno, aveva anticipato l’intenzione della piattaforma di apportare una maggiore trasparenza sui profili. Intento assolutamente lodevole.
La fase di test era partita sugli account dei dipendenti X, con l’obiettivo dichiarato di aiutare gli utenti a verificare l’autenticità dei contenuti che visualizzano quotidianamente e limitare l’influenza delle cosiddette “troll farm”.
La funzione, accessibile toccando la data di iscrizione visibile sui profili, mostra una serie di informazioni fino a quel momento nascoste: il Paese o la regione da cui l’account viene utilizzato prevalentemente; la data di creazione dell’account; il numero di volte in cui è stato cambiato il nome utente con l’indicazione dell’ultimo cambio; e la modalità attraverso cui l’app è stata scaricata originariamente (App Store statunitense, Google Play, web e così via).
Il meccanismo tecnico si basa sull’analisi degli indirizzi IP aggregati e sui dati dello store da cui è stata scaricata l’applicazione. X ha anche predisposto un sistema di avvisi per segnalare quando vengono rilevate connessioni attraverso proxy o VPN, mostrando un’icona a scudo con la dicitura che il Paese o la regione potrebbero non essere accurati.
Come si sa, gli utenti hanno la possibilità di modificare le impostazioni sulla privacy, scegliendo se mostrare il Paese specifico o solo la macro-regione geografica (Europa, Asia, Africa).
Questa opzione, inizialmente pensata per tutelare utenti in Stati dove la libertà di espressione è limitata, è stata poi estesa a tutti gli utenti. In ogni caso, come precisato da Bier, l’attivazione dei controlli sulla privacy viene evidenziata sul profilo stesso, creando un ulteriore livello di segnalazione che potrebbe alimentare sospetti.
Lancio globale e l’immediato caos
Quando la funzione è stata attivata a livello globale, sabato 22 novembre, si è scatenato un prevedibile parapiglia. Utenti di ogni orientamento politico hanno iniziato a verificare la posizione geografica di account con cui interagivano da anni, scoprendo incongruenze spesso clamorose.
I dati emersi nelle prime ore di utilizzo hanno mostrato situazioni e scenari sorprendenti.
L’account MAGANationX, con quasi 400.000 follower e che si presenta come “voce patriottica del popolo americano”, è risultato basato in Europa orientale al di fuori dell’Unione Europea.
IvankaNews_, account dedicato a Ivanka Trump con quasi un milione di follower, è apparso localizzato in Nigeria. Altri profili molto seguiti che promuovono contenuti pro-MAGA sono stati identificati in Bangladesh (account “America First” con 67.000 follower), Thailandia (Dark Maga con 15.000 follower), Marocco e Macedonia.
Ma il fenomeno non ha risparmiato neanche l’altro lato dello spettro politico. Un account che si presentava come “democratico orgoglioso” e “cacciatore professionale di MAGA”, con 52.000 follower, è stato localizzato in Kenya.
L’account “Republicans Against Trump”, con quasi un milione di follower, è risultato basato in Austria, anche se successivamente la localizzazione è cambiata in USA con l’avviso di possibile uso di VPN.
Il caso più eclatante, però, è stato quello dell’account del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Venerdì mattina hanno iniziato a circolare screenshot e video che mostravano l’account come “basato a Tel Aviv, Israele”.
https://t.co/Xe6MVghyfV pic.twitter.com/4PJNovdEQT
— Homeland Security (@DHSgov) November 22, 2025
La funzionalità è stata disattivata bruscamente venerdì sera, alimentando dubbi sul fatto che X avesse ritirato lo strumento proprio per sopprimere la controversia legata all’account governativo.
Il DHS ha inizialmente risposto con un meme che mostrava Trump con espressione stupita, senza confermare né smentire, per poi pubblicare domenica una smentita ufficiale affermando che l’account è sempre stato gestito esclusivamente dagli Stati Uniti.
Nikita Bier ha respinto con forza le speculazioni, definendo le affermazioni “fake news” e spiegando che la funzione era stata temporaneamente disattivata “perché il Paese di creazione dell’account era inesatto per un sottoinsieme molto piccolo di account vecchi, a causa di intervalli IP cambiati nel tempo”.
Bier ha inoltre precisato che le informazioni sulla posizione non erano (e non lo saranno) disponibili per gli account verificati grigi (governativi e istituzionali), e che i post che mostravano il contrario erano stati etichettati come “media manipolati”.
Tanti i limiti e le imprecisioni
La temporanea disattivazione ha rivelato problemi tecnici più profondi di quanto inizialmente ammesso. Sabato sera, Bier ha dichiarato che i dati “non erano precisi al 100%, specialmente per gli account più vecchi” e che l’obiettivo era ripristinare le informazioni sulla creazione dell’account entro martedì.
Cinque ore dopo ha pubblicato un laconico “ho bisogno di un drink”, sintomo della pressione che si stava accumulando.
Quando la funzione è stata riattivata domenica mattina, X aveva già operato modifiche significative. L’informazione sul Paese di creazione originale dell’account era stata rimossa completamente, lasciando solo la posizione corrente basata, rispetto a quello che è stato diffuso inizialmente.
Gli account istituzionali con spunta grigia ora mostrano solo la data di creazione e quella di verifica, senza alcuna indicazione geografica, con l’eccezione dell’account DHS che è l’unico profilo governativo a mostrare “Stati Uniti” come posizione.
Le cause tecniche delle imprecisioni sono molteplici. L’uso di VPN o proxy può alterare la localizzazione rilevata. Gli indirizzi IP dinamici, i servizi di hotspot mobile e connessioni di tipo satellitare possono generare dati geografici errati.
Gli intervalli di indirizzi IP cambiano nel tempo, rendendo obsolete le informazioni di localizzazione storica per account creati anni fa. Viaggi internazionali e trasferimenti di residenza creano ulteriore complessità.
Appena attivata ho personalmente verificato diversi casi problematici. Il mio stesso account è stato segnalato come “probabilmente collegato via VPN” quando così non era e non è mai stato. Con il risultato di generare un’informazione completamente errata. Vero è che la mia posizione è in Italia.
Ma c’è di più. Profili che si dichiaravano italiani risultavano attivi stabilmente nel Sud-Est asiatico. E da ui si potrebbe creare una lista lunghissima di account.
Di fronte a questa funzionalità, molto valida nel suo intento, va assunto un atteggiamento attento. Proviamo ad immaginare due esempi.
Come approcciare alla funzionalità
Un account creato nel 2023, localizzato in India, con decine di cambi di username in pochi mesi e contenuti esclusivamente anti-Unione Europea presenta tutti i segnali di un’attività non autentica.
Invece, un profilo del 2011 con posizione sempre in Italia, verifica dal 2017 e attività coerente nel tempo lascia immaginare che sia un utente reale.
Bier ha riconosciuto che persistono alcune imperfezioni che dovrebbero essere risolte entro martedì 25 novembre, sottolineando che “se qualche dato è scorretto, verrà aggiornato periodicamente in base alle migliori informazioni disponibili” e che questo avviene “con una pianificazione ritardata e randomizzata per preservare la privacy”.
Le implicazioni politiche
Al di là degli aspetti tecnici, la funzione ha riacceso un dibattito, mai sopito in realtà, sull’effettiva portata dell’interferenza straniera nelle conversazioni politiche online.
Secondo le verifiche condotte da diversi analisti nelle prime ore di attivazione della funzione, decine di account con follower che vanno dalle decine di migliaia al milione sono risultati basati in Paesi diversi da quelli che i loro contenuti suggerivano.
Il Centre for Information Resilience aveva già segnalato durante le elezioni statunitensi del 2024 l’uso di account basati in Europa orientale o Russia per amplificare il movimento MAGA. La nuova funzione ha finito per rivelare informazioni alimentando ancora di più sospetti rispetto ad alcuni account.
Quando un utente ha chiesto a Grok, il chatbot di IA integrato in X, se il fenomeno riguardasse entrambi gli schieramenti politici, la risposta è stata: “I recenti aggiornamenti di X con le etichette dei Paesi hanno evidenziato diversi account pro-Trump/MAGA come basati all’estero, spesso in Russia. Le ricerche mostrano meno report di account democratici esposti in questo evento specifico, anche se operazioni di influenza straniera hanno storicamente preso di mira entrambi gli schieramenti politici“.
Recent X updates with country labels have highlighted several pro-Trump/MAGA accounts as foreign-based, often Russian. Searches show fewer reports of Democrat accounts exposed in this specific event, though foreign influence ops have targeted both political sides historically,…
— Grok (@grok) November 23, 2025
Anche account che si presentavano come giornalisti a Gaza o voci palestinesi sono stati esposti come basati in Turchia, Pakistan o altri Paesi, sollevando interrogativi sulla genuinità di contenuti che hanno raccolto milioni di visualizzazioni durante periodi di crisi internazionale.
Il paradosso della trasparenza
La vicenda solleva questioni più profonde sulla natura stessa della trasparenza nelle piattaforme digitali. Uno strumento pensato per aumentare la fiducia ha finito per generare confusione, alimentato teorie di complotto e potenzialmente danneggiato la reputazione di account segnalati erroneamente.
Il problema fondamentale è che la trasparenza imperfetta può diventare addirittura più dannosa della stessa opacità.
Quando un sistema di verifica presenta margini di errore così evidenti ma viene percepito come affidabile, le conseguenze possono essere gravi.
Un utente segnalato come “probabilmente collegato via VPN” quando non lo è subisce un danno reputazionale ingiustificato. Un giornalista che lavora legittimamente dall’estero rischia di essere etichettato come troll. Un account governativo erroneamente localizzato in un altro Paese innesca enormi dubbi infondati.
La dinamica ricorda altri tentativi di introdurre meccanismi di verifica su larga scala che si sono rivelati problematici.
Le etichette automatiche di Facebook sui contenuti legati al cambiamento climatico hanno generato falsi positivi su articoli scientifici. I sistemi di moderazione automatica di YouTube hanno ripetutamente colpito contenuti legittimi mentre lasciavano passare violazioni evidenti. La differenza è che in questo caso la classificazione geografica tocca direttamente la sfera dell’identità e dell’opinione politica.
C’è poi il rischio di abuso dello strumento stesso. Utenti malintenzionati hanno iniziato a utilizzare la funzione per campagne di delegittimazione mirata, pubblicando screenshot di localizzazioni geografiche per screditare avversari politici. Tutto questo senza verificare se i dati fossero accurati o se ci fossero spiegazioni legittime (come persone che lavorano temporaneamente all’estero o che hanno creato account durante viaggi).
La possibilità di modificare le impostazioni per mostrare solo la regione invece del Paese specifico introduce un ulteriore livello di ambiguità. Se un utente sceglie di mostrare “Asia” invece di un Paese specifico, questo viene evidenziato sul profilo, creando di fatto un segnale che può essere interpretato negativamente anche quando la scelta è legittima per ragioni di sicurezza personale.
Quale trasparenza è possibile nelle piattaforme digitali?
In un ecosistema, dove secondo la società anti-disinformazione Cyabra almeno il 20% degli account che interagiscono con Elon Musk sono bot, e dove l’intelligenza artificiale rende sempre più facile creare profili che si comportano in modo indistinguibile dagli umani, quali strumenti di verifica sono effettivamente affidabili?
La risposta che emerge da questa vicenda è che la trasparenza non è un interruttore che si può semplicemente attivare. Ma è un sistema complesso che richiede precisione tecnica, capacità di comprensione e interpretazione del contesto e meccanismi di correzione.
Uno strumento di trasparenza difettoso non è solo inutile: è controproducente perché erode ulteriormente la fiducia che pretende di costruire.
X non è la prima piattaforma a offrire informazioni “su questo account”. Instagram ha una funzionalità simile da tempo, che mostra quando un profilo è stato creato e i pattern di crescita dei follower. Ma Instagram si limita a dati meno controversi e più facilmente verificabili.
La scelta di X di includere informazioni geografiche basate su dati IP, notoriamente imprecisi, rappresentava un rischio calcolato che si è rivelato del tutto sottovalutato.
Il contesto normativo europeo aggiunge un ulteriore livello di complessità. Il Digital Services Act richiede alle piattaforme di grande dimensione di aumentare la trasparenza sui contenuti e di dare agli utenti strumenti per valutare l’affidabilità delle informazioni.
La vicenda si inserisce anche nella più ampia strategia di Elon Musk di trasformare X in un'”app per tutto” dove la fiducia è fondamentale. Come sottolineato da Bier, l’obiettivo è che durante eventi come elezioni o crisi internazionali, conoscere da dove proviene un account possa fornire un contesto preciso, simile alla firma che accompagna gli articoli nel giornalismo tradizionale. Ma il paragone regge solo se le informazioni sono accurate quanto quelle di una testata giornalistica verificata.

Cosa si impara da un esempio di trasparenza imperfetta
Cosa ci dice questa vicenda sul futuro della verifica dell’autenticità online
Innanzitutto, che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. L’identificazione di bot e account inautentici richiedono l’analisi di molteplici segnali comportamentali, non solo della posizione geografica. La frequenza dei post, i pattern di interazione, la coerenza temporale del linguaggio, le reti di connessioni sono tutti elementi che, combinati, possono fornire un quadro più affidabile.
In secondo luogo, che la trasparenza deve essere accompagnata da meccanismi capaci di contestualizzare e correggere in tempo reale.
X ha dimostrato di poter reagire rapidamente disattivando e modificando la funzione, ma questo ha anche alimentato la percezione di censura e manipolazione.
Un sistema più maturo avrebbe dovuto prevedere fin dall’inizio la possibilità per gli utenti di segnalare errori e di fornire spiegazioni contestuali verificabili.
Terzo, che gli effetti collaterali della trasparenza imperfetta possono essere significativi. La funzione ha generato ondate di campagne di delegittimazione reciproca, ha esposto potenzialmente utenti a rischi e ha alimentato narrazioni cospirazioniste molto difficili da smentire una volta diffuse.
Per ora, “Info sul tuo account” rimane quello che dovrebbe essere esplicitamente dichiarato: un indicatore, non una prova. Un primo tentativo di dare contesto, non una certificazione di autenticità.
Una indicazione da mettere insieme ad altri elementi di valutazione, non una sentenza definitiva. Se gli utenti lo useranno con questa consapevolezza critica, allora potrebbe essere utile.
Se invece verrà trattato come verità assoluta, paradossalmente potrebbe alimentare più confusione di quanta ne risolva. E questa, forse, è la lezione più importante di questo caotico weekend digitale.
[Le immagini originali sono state realizzare usando modelli di IA Artificiale Generativa, come Dall-E 3, Canva Magic Media, Gemini 3]